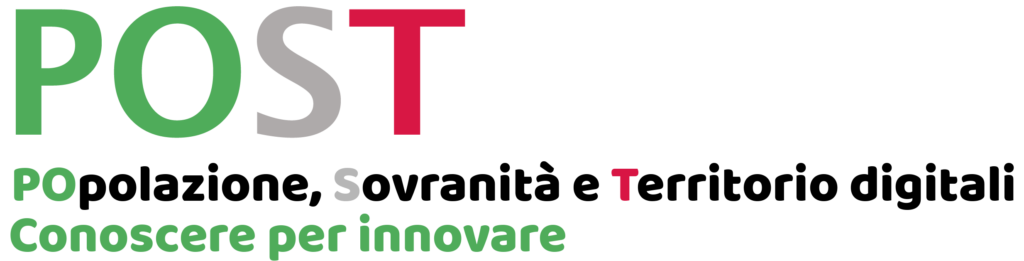La conversione a tempo indeterminato del contratto a termine stipulato tra le parti per effetto della nullità del termine accertata con sentenza successiva all’entrata in vigore del D.lgs 23/2015, ma configurante un patto modificativo di un rapporto di lavoro già instaurato e convertito prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 2015, comporta l’inapplicabilità del regime di tutela previsto dallo stesso decreto legislativo, che invece si applica ai rapporti di lavoro trasformati volontariamente o convertiti in seguito a nullità sopravvenute dopo l’avvento della nuova disciplina.
Cass., Sez. lavoro (ud. 10/12/2019) 16-01-2020, n. 823, Pres. Di Cerbo, Est. Piergiovanni
Lavoro a termine – Regime Applicabile – Jobs Act – Trasformazione – Conversione – Applicabilità
***
Chiarimenti sul lavoro a termine convertito dopo l’entrata in vigore del Jobs’ Act
di Riccardo Fratini – Avvocato in Roma e assegnista di Ricerca Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
Sommario: 1. Il principio di diritto espresso dalla Cassazione: si applica il jobs act solo ai rapporti in cui la nullità del termine sia sopravvenuta dopo il 7 marzo 2015. – 2. La natura dichiarativa dell’accertamento e la discussione sul punto. – 3. L’interpretazione costituzionalmente orientata sulla “disparità” che non ha reso pari nessuno. – 4. Le trasformazioni volontarie.
Il principio di diritto espresso dalla Cassazione: si applica il jobs act solo ai rapporti in cui la nullità del termine sia sopravvenuta dopo il 7 marzo 2015
1. La sentenza fa chiarezza sull’interpretazione dell’art. 1 del d.lgs. 23/2015 (cd. “Jobs Act”) nella parte in cui afferma che le disposizioni sulle sanzioni per i licenziamenti previste da quel decreto si applicano anche “nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato”, affermando, con argomentazione condivisibile, che l’aggettivo “successiva” debba riferirsi al momento in cui la nullità del termine opera di diritto e non a quello posteriore in cui una sentenza ne accerti la sussistenza, dovendosi quindi ritenere applicabile la disciplina delle tutele crescenti (se così ancora si possono chiamare dopo la dichiarazione di incostituzionalità) solo ai contratti in cui la nullità del termine sia sopravvenuta dopo l’entrata in vigore del decreto e dunque dopo il 7 marzo 2015, indipendentemente dalla data dell’accertamento della nullità.
I fatti a cui si dovrebbe fare riferimento per determinare il momento di insorgenza di questa sopravvenuta nullità dell’elemento accidentale sono chiaramente indicati nella sentenza:
“ a) la continuazione del rapporto di lavoro oltre trenta giorni (in caso di contratto a termine di durata inferiore a sei mesi) ovvero oltre cinquanta giorni (in caso di contratto a termine di durata superiore a sei mesi), ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 2 (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1058, in riferimento al previgente termine di venti, anzichè di trenta giorni), qualora la scadenza sia successiva al 7 marzo 2015 (da essa considerandosi “il contratto… a tempo indeterminato”);
b) la riassunzione entro dieci giorni dalla scadenza del primo contratto a termine (qualora di durata inferiore a sei mesi) ovvero entro venti giorni (in caso di contratto a termine di durata superiore a sei mesi), ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 3, qualora il secondo contratto (che “si considera a tempo indeterminato”) sia stato stipulato dopo il 7 marzo 2015;
c) il superamento “per effetto di una successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti” nel “rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore… complessivamente” dei “trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro”, sicché “il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato” (art. 5, comma 4 bis), qualora detto superamento sia successivo al 7 marzo 2015 (Cass. s.u. 31 maggio 2016, n. 11374, p.ti da 54 a 59 in motivazione, ad illustrazione delle suddette ipotesi ed in particolare di quest’ultima, debitamente differenziata, proprio in merito alla diversa decorrenza rispetto a quella di successione di contratti a termine senza soluzione di continuità, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4, per escluderne il contrasto con la clausola n. 5 dell’Accordo Quadro, recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE)”.
A queste ipotesi, che riguardano la disciplina giudicata dalla sentenza, si aggiungono gli altri fatti idonei a determinare la conversione del rapporto che ora sono previsti dal D.lgs. 81/2015, artt. 19 – 29 (cd. Disciplina organica dei contratti di lavoro) e dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. Decreto dignità). Rispetto a queste discipline, il problema della applicabilità della disciplina dettata dal Jobs Act si pone solo nel caso in cui i contratti a termine da esse regolati siano stati stipulati anteriormente al 7 marzo 2015 e, visto che la durata massima complessiva era di 36 mesi e ora è di 24 mesi, di cui 12 giustificati da causali, tali ipotesi ricorrono con meno frequenza, in quanto è difficile che la nullità di un termine sia sopravvenuta prima di tale data e, di conseguenza, nella maggior parte dei casi ci si troverà di fronte ad ipotesi di pacifica applicazione delle nuove tutele.
La natura dichiarativa dell’accertamento e la discussione sul punto
2. Il ragionamento operato dalla sentenza in epigrafe parte dall’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’accertamento della nullità della clausola appositiva del termine ha natura dichiarativa e non costitutiva, con la conseguenza che la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera con effetto ex tunc dalla illegittima stipulazione del contratto a termine.
L’orientamento ripercorre la teoria classica della nullità dell’elemento accidentale del contratto costituito dal termine finale, secondo cui la nullità della clausola appositiva del termine configurerebbe un’ipotesi di nullità parziale del contratto che non comporta la caducazione dell’intero accordo ma soltanto il venir meno della specifica disposizione riguardante il termine di scadenza del contratto medesimo.
La teoria interpretativa di derivazione civilistica della nullità parziale, che pure aveva sempre mantenuto una consistente platea di sostenitori, aveva visto una difficoltà applicativa con l’inserimento della sanzione della conversione ad opera del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ai sensi del quale il rapporto a termine in cui l’elemento accessorio fosse stato ritenuto nullo “si considera a tempo indeterminato” dalla data della stipulazione del primo contratto in caso di pluralità di contratti successivi. La formula della conversione si è protratta da quel momento in avanti fino alla formula oggi utilizzata dal Testo unico sui contratti di lavoro (D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81), secondo cui il contratto a termine posto in essere in violazione dei divieti imposti dalla legge “si trasforma” in contratto a tempo indeterminato. Una prima questione si determinava sul significato dei termini “conversione” o “trasformazione” ed in particolare se essi dovevano ritenersi utilizzati dal legislatore in senso tecnico, richiamando
Nelle more di questa disciplina della conversione era poi intervenuto il collegato lavoro (L. 4 novembre 2010, n. 183), che limitava l’operatività del principio civilistico generale quod nullum est nullum producit effectum e la conseguenziale regola secondo cui l’azione diretta a far valere la nullità è imprescrittibile (art. 1422 c.c.) e, sul piano del rapporto di lavoro, gli obblighi retributivi e contributivi persistevano anche dopo la scadenza del termine illegittimamente apposto, in forza della mora credendi del datore di lavoro costituita attraverso l’offerta della prestazione lavorativa da parte del lavoratore. Dopo il Collegato Lavoro, invece, il risarcimento per il periodo intermedio veniva limitato ad un massimo di 12 mensilità, il che faceva dubitare ulteriormente che la conversione così modificata coincidesse con la tradizionale figura della nullità parziale di derivazione civilistica.
In aggiunta, per chiarire maggiormente il punto, la Legge Fornero (L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13) introduceva una disposizione di interpretazione autentica del Collegato per affermare che l’indennità prevista ristora “per intero il pregiudizio subito dal lavoratore“, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
L’uso della locuzione “ricostituzione del rapporto di lavoro“, tuttavia, aveva fatto sorgere ulteriori dubbi interpretativi, essendo stato ipotizzato da alcuni interpreti che il legislatore avesse accreditato la tesi secondo cui la conversione del rapporto opera ex nunc e non ex tunc.
Secondo la giurisprudenza, tuttavia, tali dubbi interpretativi sarebbero ora fugati dalla sentenza della Corte costituzionale 8 luglio 2014, n. 226 che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 11 e 117 Cost., in relazione alla clausola 8.3 dell’Accordo Quadro Europeo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, secondo cui la ratio del Collegato si dovrebbe rinvenire solo nella volontà di introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione a fronte delle obiettive incertezze verificatesi nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente, con l’esito di risarcimenti ingiustificatamente differenziati in misura eccessiva, e quindi di fornire un meccanismo semplificato e di più rapida definizione di liquidazione del danno.
Nulla a che vedere dunque con la natura dell’azione di nullità, limitandosi la norma a regolare la quantificazione del danno conseguente alla stessa.
Dunque, la sentenza con cui il giudice, rilevato il vizio della pattuizione del termine, converte il contratto di lavoro in un contratto di lavoro a tempo indeterminato non può che operare ex tunc, sin dall’origine del rapporto di lavoro, il quale è da ritenere instaurato illegittimamente a termine sin dall’origine, ancorché per effetto di accertamento intervenuto ex post.
La sentenza che accerta la nullità del termine, quindi, implica la ricostituzione della funzionalità del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l’obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore e di corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva ed a prescindere dal fatto che quanto dovuto per il danno nel periodo intermedio decorrente tra la scadenza del termine e la dichiarazione di nullità sia forfettizzato nell’indennità prevista dall’art. 32 del Collegato.
L’interpretazione costituzionalmente orientata sulla “disparità” che non ha reso pari nessuno.
3. Le sole considerazioni, secondo cui tempus regit actum e, quindi, l’accertamento compiuto in sede di sentenza con riguardo alla nullità del termine ha natura dichiarativa, sarebbero bastate da sole a giustificare il principio di diritto secondo cui la tutela da applicare in seguito alla conversione va determinata in ragione dell’evento a cui la legge connette questo effetto e non alla data della sentenza che lo accerta e dichiara.
Tuttavia, la sentenza si pone anche la questione relativa alla ragionevolezza del regime introdotto dalle due possibili interpretazioni. Secondo la pronuncia, infatti, se si interpretasse la norma nel senso di affermare che la conversione ha riguardo alla pronuncia e non al factum principis, questo “comporterebbe un’evidente quanto irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori egualmente assunti a tempo determinato prima della sua introduzione ma con la conversione del rapporto, per nullità del termine, in uno a tempo indeterminato in base a sentenze emesse tuttavia, per mero accidente indipendente dalle rispettive volontà, talune prima, altre dopo tale data”.
L’argomento pone il tema della parità di trattamento nel diritto del lavoro privato dopo la sentenza costituzionale n. 194/2018, che allo stesso modo poneva questo tema come base per cancellare le tutele crescenti.
Già in quella sede, infatti, la Corte affrontava, in via preliminare, la questione di costituzionalità della diversità di disciplina applicabile, rispettivamente, ai lavoratori assunti prima del marzo 2015 e a quelli assunti dopo, questione sollevata in base alla indiscutibile premessa del carattere deteriore della disciplina applicata ai secondi rispetto a quella applicata ai primi. In quel caso la disparità non era ragionevole in quanto legata ad un elemento – la data di stipulazione del contratto di lavoro – del tutto estraneo al tema delle sanzioni per il licenziamento ingiustificato. Autorevole dottrina non ha mancato di sottolineare come la risposta della Corte fosse in quella sede assai discutibile. Essa infatti si limitava a richiamare i “consueti princìpi” che regolano il succedersi di diverse normative: il fluire del tempo costituisce un plausibile elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche e, quindi, la disparità fra il “prima” e il “dopo” è il necessario corollario della successione delle leggi nel tempo. Ma nel caso in oggetto sembra esserci qualcosa di più del mero succedersi di discipline ognuna operante nel suo ambito ratione temporis: non ci sono diverse normative che si susseguono, ma due diverse normative che contemporaneamente regolano lo stesso fatto nello stesso tempo, il licenziamento, ma diversificate sulla base di un elemento del tutto esterno come la data di assunzione/conversione. Questa discrepanza è ancora più evidente nel caso del licenziamento collettivo dove la violazione dei criteri di comparazione, in ipotesi fra lavoratori vecchi e nuovi assunti, produce effetti incomprensibilmente diversi, che infatti saranno ora vagliati dalla Corte di Giustizia UE alla luce del diritto dell’Unione.
Lo stesso problema si pone anche nel contratto a termine che è oggetto della sentenza in commento e quindi sarebbe stato plausibile un ulteriore rinvio alla Corte Costituzionale, ma qui la Corte di Cassazione ha preferito trattenere la questione, applicando direttamente i medesimi principi già espressi nella sentenza 194/2018 ed “eliminando la disparità”.
Vi è da dire, però, che la disparità, nell’era del “diritto liquido” è diventata la chiave di volta di ogni decisione discrezionale delle Corti e, di conseguenza, il mantra degli avvocati nei ricorsi di lavoro. Anche perché a voler vedere bene una disparità resta comunque anche con la decisione in epigrafe, in quanto i lavoratori che hanno stipulato il contratto a termine illegittimo dopo il 7 marzo 2015 sono comunque trattati in modo diverso (anche se non più deteriore) rispetto a quelli convertiti prima. Ed anzi, qualcuno potrebbe dire, che visto che ora la forbice del risarcimento tra 6 e 36 mensilità è più vantaggiosa di quella di cui al 18 Stat. Lav. nuovo testo, allora si potrebbe dire che il principio di diritto pronunciato ha un effetto diminutivo dei diritti dei lavoratori e non è affatto un orientamento favorevole alla parte debole del rapporto di lavoro.
Inoltre, sarebbe opportuno chiedersi se quella tra vecchi e nuovi assunti/convertiti sia davvero una disparità costituzionalmente rilevante.
Se si ha riguardo alle altre pronunce precedenti alla sentenza 194/2018, si scopre che la moda della disparità è molto recente e che questo argomento in precedenza faceva poca presa sui giudici delle leggi.
Nel 2011, ad esempio, la Corte Costituzionale riteneva di fondare una pronuncia di incostituzionalità sull’argomento della disparità, che tuttavia veniva in rilievo come vulnus costituzionale denunciato con riferimento al principio di uguaglianza, identificato “nella disparità di trattamento tra lavoratori aventi diritto alla mobilità e lavoratori che, pur disoccupati, ne sono esclusi“. Il caso qui era chiaro: identità di situazioni soggettive di fronte alla legge, ma disparità di trattamento.
In altre situazioni, invece, in cui il tempo e la transitorietà di una disciplina rendevano il caso meno chiaro e più soggetto alla discrezionalità, la Corte aveva ritenuto pienamente legittime le differenziazioni, come nel caso dell’età massima per la stabilità del rapporto, diversificata per uomini e donne, in via transitoria.
Più di recente la questione della disparità era venuta in rilievo ed era stata respinta persino con riferimento alla differenza tra il datore di lavoro che adempia alla sentenza di reintegrazione e quello che decida di non adempiervi, dato che il primo, inadempiente, può vedersi restituito tutto quanto corrisposto, mentre il secondo, adempiente, non potrebbe comunque richiedere indietro la retribuzione corrisposta per il lavoro effettivamente prestato.
Allo stesso modo era stata respinta la questione relativa alla parità di trattamento retributivo per i lavoratori indiretti, che erano pagati meno solo perché dipendenti dei subappaltatori pur in completa identità di mansioni rispetto ad altri lavoratori dell’appaltante.
Insomma, si potrebbe dire che il tema della disparità è stato molto utilizzato, ma non aveva in fin dei conti molta fortuna. Si era rimasti sempre alla teoria classica secondo cui la discriminazione e la parità di trattamento operano quali istituti previsti da norme specifiche ed in casi tipici, salvo il caso di gravi e comprovate situazioni di disparità che si sono determinate a causa del progressivo mutamento della società, come ad esempio il caso del riconoscimento dei permessi previsti dalla L. 104/1992 in favore del convivente more uxorio. Per il resto la discrezionalità era lasciata al legislatore, che poteva decidere come e quando concedere o abrogare tutele, purché una qualche tutela ragionevole e dissuasiva fosse approntata.
Dopo la sentenza 194/2018, invece, sembra che la disparità di trattamento abbia assunto un nuovo ruolo: una argomentazione “in voga”, perseguendo la quale la Cassazione si è trovata ad affermare in modo impreciso che l’interpretazione data serviva a raddrizzare una disparità (sentenze emesse prima, sentenze emesse dopo). Il risultato paradossale è che la pronuncia non ha affatto eliminato la disparità, che resta tra convertiti prima e convertiti dopo e che, peraltro, è ora invertita rispetto a prima perché i nuovi assunti sono più tutelati dei vecchi assunti.
Forse era meglio quanto il diritto era meno liquido e “disparità” indicava solo la condizione di due soggetti nella medesima posizione trattati in modo diverso, come è, in una certa misura, solo per i lavoratori soggetti al licenziamento collettivo che abbiano pari anzianità.
Le trasformazioni volontarie.
4. Sotto un altro profilo, la sentenza chiarisce definitivamente che tra le ipotesi di applicazione del Jobs’ Act rientrano anche le trasformazioni volontarie, che invece qualche sentenza di merito aveva ritenuto di escludere, come evidenziato in un precedente lavoro[1], a cui sia concesso di operare un richiamo.
Rispetto alla questione, è sopravvenuta soltanto un’ulteriore sentenza del Tribunale di Parma[2], che aveva originalmente affermato una terza opinione rispetto alle due precedentemente affermate.
Oltre all’interpretazione più corretta, ora affermata nella sentenza in epigrafe, infatti, era stata paventata solo quella contraria, affermata dal Tribunale di Roma[3], secondo cui nel campo di applicazione del d.lgs. 23/2015 sarebbero ricomprese solo le ipotesi di nuove assunzioni o le ipotesi di contratti a tempo determinato stipulati prima dell’entrata in vigore del Jobs Act che abbiano subito una “conversione” in senso tecnico in data successiva al 7 marzo 2015 per via giudiziale, mentre non sarebbero ricomprese le ipotesi di “trasformazione”, di fatto o con manifestazione esplicita di volontà, del rapporto stipulato in data antecedente, quando il rapporto semplicemente prosegua, senza interruzione, oltre tale data.
Il Tribunale di Parma, invece, sosteneva l’opposta, e ugualmente erronea, opinione, secondo cui la “conversione” non sarebbe quella giudiziale, ma solo quella intesa come trasformazione/prosecuzione di tipo negoziale del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, per accordo tra le parti del contratto medesimo. La ragione risiederebbe nel fatto che la conversione operata in sede giudiziale di un contratto a termine determinerebbe la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con efficacia ex tunc, perciò incompatibile con il campo di applicazione della disciplina del contratto a tutele crescenti, delimitato da criteri di tipo temporale, per i quali rileva esclusivamente la data di costituzione del rapporto di lavoro.
L’interpretazione corretta, ora finalmente chiarita dalla Corte, invece, non può che essere quella che si era proposta nel lavoro già citato, secondo cui la distinzione terminologica tra trasformazione e conversione non trova riscontro normativo, visto che sia il legislatore che la giurisprudenza hanno sempre utilizzato le due espressioni come sinonimi. Il discrimen per l’applicazione delle tutele crescenti, invece, non va ricercato nella formula utilizzata dalle parti o dal giudice, ma nel momento da ritenere significativo per la trasformazione del contratto, che nel caso di valutazione negoziale è quello di stipulazione del contratto a tempo indeterminato, mentre nel caso di valutazione giudiziale è quello relativo alla sopravvenuta nullità dell’elemento accidentale del contratto stipulato in violazione dei limiti di legge.
[1] R. FRATINI, L’intenzione travisata del ‘Jobs Act’: conversione non vuol dire trasformazione [Nota a ordinanza: Tribunale di Roma, sez. lav. 6 agosto 2018, n. 75870], in LPO, 2018, 11/12, 684-690;
[2] T. Parma 18 febbraio 2019, in Rep. Foro it., 2019, Lavoro (rapporto) [3890], n. 1050;
[3] T. Roma 6 agosto 2018, con nota di R. FRATINI, L’intenzione travisata del ‘Jobs Act’: conversione non vuol dire trasformazione, cit.;